Le Fasi della Vita Monastica - 3° Fase
La voce del Maestro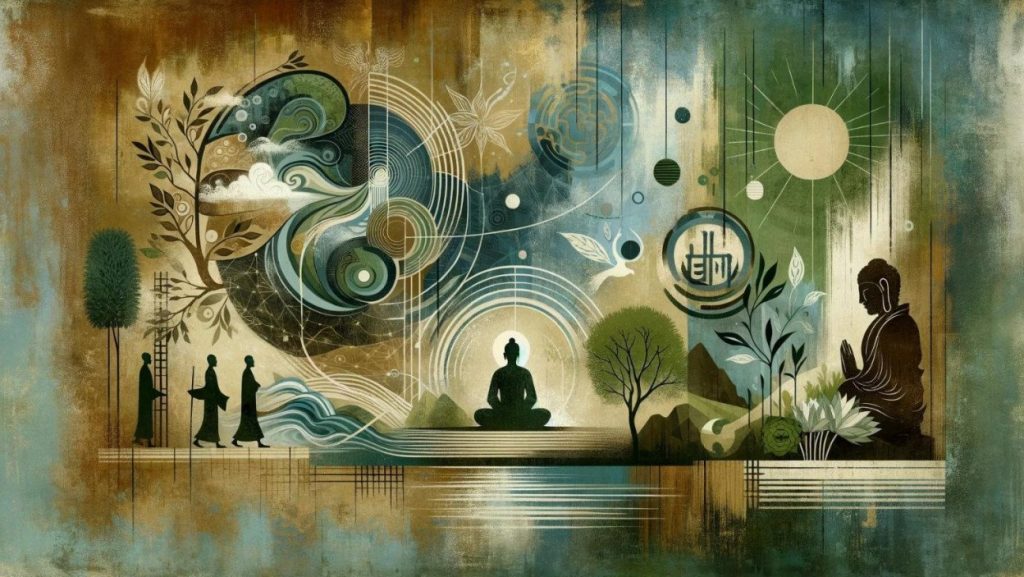
Verso la verità
……..Eppure, il tempo svolge il suo ruolo: con il passare dei giorni, le cose si chiariscono e il nuovo cammino si disegna più nettamente, permettendo il nostro sviluppo. Lentamente superiamo l’incertezza iniziale, adattandoci al nostro nuovo ruolo. Ricostruiamo le nostre vite, abbracciando nuove pratiche e modalità di apprendimento. I legami con il dharma si approfondiscono, le illusioni si dissolvono e lasciamo andare le aspirazioni che non contribuiscono al nostro cammino. Il tempo scorre, e noi con lui prendiamo il nostro posto nel suo fluire.
Ma non conosciamo ancora le vere prove che ci aspettano dietro l’angolo…..
Nella quinta fase, ci troviamo in un luogo arido, spesso senza rendercene conto, perché non siamo mai completamente bravi nel lasciar andare. Restiamo ancora legati al nostro passato, anche quando sembra che l’abbiamo abbandonato. Questo legame sottile non sempre è evidente, e potremmo non accorgercene, continuando nella nostra pratica con sincerità. Ma, a un certo punto, la stabilità che credevamo di aver raggiunto diventa il nostro stesso limite. Cominciamo a sentirci opachi, a volte annoiati, come se avessimo perso l’acume di una mente sempre curiosa e desiderosa di scoprire.
Ora ci troviamo intrappolati nella routine, rispettati per l’esperienza accumulata. Comprendiamo gli insegnamenti, o almeno li abbiamo ascoltati così tante volte da considerarli ormai familiari. Non possiamo tornare alla nostra vita di prima, eppure ci appare impossibile vedere chiaramente quale strada seguire in avanti. Ci sentiamo bloccati.
Poi… sorge la paura. Temiamo che il cammino verso la comprensione rimarrà per sempre invisibile a noi, insieme al mondo che abbiamo dovuto abbandonare e alle nostre trasformazioni personali. Dobbiamo affrontare ogni giorno le sfide del mondo, ma raramente avvertiamo questa lotta interna. Ogni giorno affrontiamo le sfide della vita comunitaria, ma raramente riconosciamo la battaglia più silenziosa, quella che si svolge dentro di noi. Eseguiamo le nostre pratiche e mansioni giornaliere nel monastero con regolarità, ma non ci accorgiamo che, a poco a poco, qualcosa in noi si sta consumando: un sé, una spinta, una luce.
Il cammino, fino a questo punto, ci ha offerto ostacoli e occasioni di crescita. Ma ora sembra che non ci siano più ostacoli, e al tempo stesso, che non ci sia più crescita.
Ed è proprio questo il problema.
Una paura sottile si è nascosta sotto la superficie: si è travestita da quiete, ma è una quiete spenta.
Abbiamo confuso l’opacità con la pace. Ci illudiamo che questo stato pigro e incolore sia la rinuncia autentica. Ma in verità, la nostra mente è sì calma… ma non luminosa. Non viva.
La creatività si affievolisce.
La passione si ritira.
L’umanità si dissolve lentamente dalle nostre giornate.
E noi quasi non ce ne accorgiamo.
Questa è forse la fase più difficile da riconoscere, da nominare, da condividere…da apprezzare.
Spesso nemmeno i membri più anziani della comunità del Sangha, nemmeno i maestri, riescono a vedere ciò che stiamo attraversando.
Non per mancanza di compassione, ma perché questa ombra è silenziosa, invisibile, e profondamente personale.
Coloro che guidano la comunità attraverso queste fasi spesso restano inconsapevoli del proprio stesso passaggio. È una delle ironie più sottili e dolorose: ciò che per anni è stato vissuto come cura, rifugio, via… ora si trasforma lentamente nel veleno invisibile che ci consuma.
È difficile da vedere. È sottile, silenzioso, spesso mascherato da diligenza, fedeltà o continuità.
Questa trasformazione può passare inosservata persino a chi la vive in prima persona.
A volte riconosciamo questo stato negli altri, ma non troviamo le parole, o il coraggio, per nominarlo. E se lo facciamo, spesso ci scontriamo con il rifiuto. Nessuno vuole che ci venga detto che ciò che ho amato, ciò che è servito alla pratica, sta ora svuotando lentamente la propria vita.
Per superare questo punto, per attraversare davvero questa soglia potrebbe essere necessario un distacco temporaneo dalla comunità o un approccio rivoluzionario per trasformare la situazione esistente. Ma ciò è difficile: quando si sono spesi anni, decenni, per costruire un percorso, abbandonarlo o cambiarlo profondamente può sembrare un tradimento, o un crollo dell’identità stessa.
La paura, che sia visibile o sotterranea, è la barriera più grande. Ci impedisce di cambiare passo, di abbandonare ciò che non nutre più il cuore. E questa condizione può durare molto, persino per tutta la vita, se non viene illuminata con onestà.
Non è una dinamica che riguarda solo la vita monastica.
La stessa fatica si manifesta nei rapporti, nelle carriere, nelle vocazioni più sincere.
Colpisce chiunque abbia costruito qualcosa con devozione, e poi, in silenzio, scopra che ciò che ha costruito non lo sostiene più.
Koan: Il rifugio che diventa gabbia
Un monaco chiese al maestro:
«Ho vissuto a lungo nel tempio. La via che mi ha nutrito ora mi soffoca. Devo andarmene?»
Il maestro rispose:
«Se la barca ti ha portato sull’altra riva, perché continui a remare nel fiume?»
Il monaco chiese:
«Ma senza la barca, come attraverserò la prossima corrente?»
Il maestro rise e disse:
«Quando lasci la barca, scoprirai che sai nuotare».
Ciò che un tempo ci ha salvati, la disciplina, la comunità, la pratica stessa, inizia a diventare un limite. Non perché abbia perso valore, ma perché noi siamo cambiati. Il maestro non invita alla fuga, ma alla trasformazione del rapporto con il cammino. La barca non è sbagliata: è stata necessaria. Ma se continuiamo a restare ancorati ad essa anche dopo aver attraversato il fiume, rischiamo di confondere il mezzo con la meta. La paura del monaco è comprensibile: dopo tanto tempo in un modo di vivere, l’idea di lasciarlo sembra pericolosa, persino ingiusta. Ma il maestro risponde con fiducia nella natura profonda del praticante: “scoprirai che sai nuotare”.
Il Dharma non si perde lasciando una forma; il Dharma si ritrova in ogni forma, se c’è sincerità e apertura.
A volte, quando ci troviamo ancora in uno degli stadi precedenti del cammino, ci illudiamo di essere giunti a questa fase matura. Sentiamo il peso del percorso, avvertiamo stanchezza, disillusione, e crediamo che sia saggezza. Allora lasciamo la barca, convinti di essere già sulla riva. Ma non c’è alcuna riva sotto i nostri piedi. È in quel momento che affondiamo.
E il pericolo più grande è che non ce ne accorgiamo. Scambiamo la stasi per liberazione, il torpore per pace, l’apatia per equanimità. In questa nebbia, persino il vuoto che ci inghiotte può sembrarci Sunyata, il Vuoto Zen. Ma non è il Vuoto liberante della consapevolezza interdipendente, è un Nulla chiuso, sterile, una fuga mascherata da illuminazione. Lo Zen non è assenza di vita, ma pienezza senza attaccamento.
Il Vuoto autentico non spegne il cuore: lo rende trasparente.
In questa fase è fondamentale essere onesti, non con i concetti, ma con la propria esperienza viva.
Chiederci: Sto lasciando andare perché ho compreso, o perché sono esausto? Questo silenzio che provo… è quiete profonda o chiusura?
Ma anche quando siamo realmente arrivati in questa quinta fase, è qui che dobbiamo prestare la massima attenzione. È facile, troppo facile, scambiare questo momento per un compimento. Illuderci di aver “attraversato il fiume”, come si dice nello Zen, e credere di proseguire liberamente, oltre le vecchie illusioni. Ma questa apparente libertà può essere solo un’altra forma di attaccamento, più sottile, più insidiosa. Siamo in una fase delicata, una soglia silenziosa: tra ciò che eravamo e ciò che ancora non siamo. Qui la pratica non ci consola, ma ci espone. Qui non si tratta più di andare avanti né di tornare indietro, ma di vedere con chiarezza dove siamo davvero, senza raccontarci storie. La mente, se non vigilante, può confondere stasi con realizzazione, distacco con rinuncia, pace con spegnimento. E così, proprio quando crediamo di esserci liberati, potremmo essere più imprigionati che mai, ma da forme nuove, più raffinate, che assomigliano alla libertà.
Un Sangha impegnato nella verità vive secondo ritmi differenti rispetto ad altre comunità. In un contesto del genere, ogni rivelazione interiore, anche silenziosa, risuona nell’intero tessuto comunitario, trasformando non solo chi la vive, ma anche chi le è intorno. Quando però una malattia invisibile, che sia stanchezza, disillusione, disconnessione o paura, si insinua anche solo in pochi membri, essa agisce come un’infezione sottile: tocca tutti. Non si diffonde attraverso parole o gesti, ma attraverso ciò che non viene detto, attraverso la delicatezza ferita della presenza. I segnali sono spesso impercettibili: un irrigidimento nei rapporti, un calo nella trasparenza, una tensione nell’aria che non ha nome. Il flusso della comunicazione si interrompe lentamente. La disonestà non è esplicita, anzi, raramente è cosciente, ma qualcosa si rompe. Un filo che univa smette di vibrare. Eppure, anche se non lo riconosciamo con chiarezza, lo sentiamo tutti. Per questo, in questi momenti, è essenziale non chiudersi, ma restare aperti alla possibilità di vivere pienamente la sincerità: con coraggio, anche quando fa male. Perché proprio questi passaggi difficili sono porte. Possono trasformarsi in occasioni per approfondire la comprensione, rallentare, accogliere il tempo della guarigione e dell’ascolto reciproco. Superare questi deserti, questi “luoghi aridi” dell’anima, non è mai un percorso solitario. Serve il Sangha. Serve l’amore degli altri, che non giudica né corregge, ma accompagna. Serve uno spazio condiviso dove possiamo permetterci di essere vulnerabili senza timore.
E così, senza cause apparenti, senza spiegazioni lineari, torna la luce. Una luce semplice, fatta di piccole cose: una risata condivisa, una pratica in silenzio, uno sguardo che dice “sono qui”.
E proprio lì, senza rumore, riappare la felicità profonda della vita monastica e del Sangha vissuta insieme.
Se superiamo questa fase allontanandoci dal Sangha, per poi rientrare, o rimaniamo lottando dall’interno, sviluppiamo un profondo rispetto per la tradizione, che ora comprendiamo come la nostra vera casa, mentre creiamo legami emotivi con maestri antichi che vediamo come nostri cari parenti. I testi che prima sembravano mistici o misteriosi ora li leggiamo come storie personali. Siamo grati per il luogo del monastero e per le persone che lo hanno fondato e supportato nel corso della storia. La nostra vita diventa segnata dalla gratitudine. Troviamo gioia nei nostri sforzi per condividere gratitudine in ogni situazione e attraverso tutti i metodi di espressione disponibili. Questa è la sesta fase, che si presenta come la fase dell’apprezzamento.
Col tempo, questa forma di apprezzamento silenzioso, che all’inizio era come una gratitudine spirituale, intima e gioiosa, si fa più semplice, più ordinaria. Non perde profondità, ma si radica nella quotidianità. Iniziamo a prenderci cura con maggiore naturalezza degli aspetti pratici della vita del monastero, del Sangha, del luogo che ci ospita. E, quasi senza accorgercene, ci sorprende la bellezza concreta delle persone con cui pratichiamo ogni giorno.
Ne vediamo chiaramente i difetti, come vediamo i nostri, che non sono affatto scomparsi, eppure qualcosa è cambiato. Inizia a emergere un senso di perdono naturale, che nello Zen si chiama Sange; una gratitudine anche per le nostre imperfezioni, e proprio grazie a questa comprensione ci apriamo ai limiti degli altri con lo stesso spirito. Non idealizziamo. Vediamo gli altri così come sono: confusi, stanchi, generosi, ostinati, profondi. Ma proprio in questa umanità fragile e sincera, li amiamo. Li amiamo come si ama il cielo quando è coperto, gli alberi quando perdono le foglie, la tradizione anche quando ci sfida.
Sappiamo distinguere la critica infinita, sterile e petulante che abbiamo sempre praticato da quella costruttiva amorevole e compassionevole. Sviluppiamo il desiderio sincero di sostenere ciò che è buono, vero e vivo. Questo è uno degli insegnamenti più maturi della pratica: non la perfezione, ma la comunione nella nostra imperfezione.
Questo amore è diverso dall’amore che conoscevamo prima, perché questo amore non include molto attaccamento. Siamo disposti a lasciare andare le persone, i luoghi e le idee. In effetti, questa disponibilità a lasciare andare è la parte più essenziale del nostro amore. Sappiamo che saremo eternamente con queste persone e che, ovunque andremo, vedremo queste stesse persone, anche se non le vedremo mai più. Perciò non abbiamo bisogno di temere o preoccuparci. Siamo disposti a vederli invecchiare, ammalarsi e morire, a prenderci cura di loro, a seppellirli e a gioire nel farlo. Copriamo la tomba con un po’ di terra, cantiamo un Sutra e ce ne andiamo pieni della gioia di sapere che, anche in mezzo alla nostra tristezza, nulla è stato perso, nessuno è andato da nessuna parte. Una vita bella che era bella all’inizio e nel mezzo è diventata ancora più bella alla fine, fino al punto di perfezione. Il genitore o l’amico che stiamo seppellendo è il Buddha, e quanto siamo stati privilegiati per tanto tempo nel vivere con loro e nel poter continuare a vivere con loro nella memoria e nei piccoli atti della nostra vita quotidiana nel monastero. Sappiamo anche che seguiremo quella strada anche noi, e che facendo questo possiamo beneficare gli altri, e dare agli altri ciò che ci è stato dato nel passaggio di questo fratello o sorella. Questa è la settima fase, la fase dell’amore.
L’ottavo stadio del nostro cammino, se così si può ancora chiamare, è lo stadio del lasciare andare tutto. Ma va detto ancora una volta: questi stadi non sono scale da salire, né tappe da attraversare con ordine. Si intrecciano, si sovrappongono, si dissolvono l’uno nell’altro, come nuvole nel cielo. In questo stadio, non resta più nulla da trattenere: non c’è più “praticare” ma pratica, non c’è “via” ma cammino, non ci sono “insegnamenti” né “maestri”, ma realizzazioni e compagni di vita.
Rimane solo la vita stessa, così com’è.
Spoglia, vasta, mutevole, luminosa.
Si può restare nel monastero o andarsene. Stare con queste persone o con altre. Vivere o morire.
Tutto questo ha il medesimo sapore. Il desiderio di beneficiare gli esseri è ancora presente, ma ormai è senza sforzo.
Come potremmo non farlo?
La compassione non è più un’azione, ma lo spazio stesso in cui respiriamo.
Abbiamo ancora un corpo, una mente, dolori e stanchezze. Ma non sono più un ostacolo: sono semplicemente gli strumenti con cui la vita si manifesta. I nostri problemi diventano il linguaggio stesso del Dharma, le sue sillabe incarnate.
Non c’è molto da dire. Non c’è molto da fare…… Si cammina e si guarda, con il cuore aperto.
Come nel koan di Unmon (Mumonkan):
“Il mondo è vasto e sconfinato.
Perché indossi la tua veste a sette pezzi
al suono della campana?”
Il risveglio non è qualcosa da raggiungere. È ciò che rimane quando non c’è più nulla da proteggere.
Conclusione
Gli stadi descritti in questa rappresentazione, per quanto idealizzati, non appartengono solo alla vita monastica: riflettono il cuore umano nel suo avanzare verso la completezza, ovunque si trovi. La vita nel monastero rende più chiara la direzione spirituale, perché è a questo che tende fin all’inizio: a fare spazio al risveglio. Per questo, ogni persona dovrebbe fare almeno un tratto di strada in un monastero, come nelle antiche tradizioni buddhiste, anche solo per un periodo. Ciascuno di noi porta in sé un seme monastico, un nucleo silenzioso che desidera ascoltare, contemplare, lasciar andare. Riconoscere almeno una volta un monastero come casa del proprio io più profondo è qualcosa che può lasciare un segno per tutta la vita, e, se perduto, genera un rimpianto sottile ma persistente.
Chi ha vissuto in un monastero sa che, più del luogo fisico, ciò che resta è una struttura interiore, un ritmo, una consapevolezza che può essere portata con sé ovunque. Il cuore stesso può diventare un monastero, un luogo silenzioso e ordinato che ci accompagna, anche nei momenti più caotici.
Costruire questo monastero interiore richiede tempo, pazienza e cura.
Richiede fortuna e l’aiuto degli altri.
Ma, soprattutto, chiede un impegno quotidiano: nella pratica costante. È da lì che nasce una pace profonda, non separata dalla vita, ma radicata in essa.
Un rifugio vivo. Un luogo che non si può abbandonare, perché è ciò che siamo davvero.
Nel Dharma
Tetsugen Serra
Per lasciare un commento devi essere registrato.
Se sei già registrato Accedi.
Se non sei ancora registrato, Registrati

